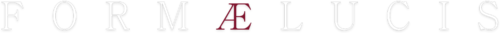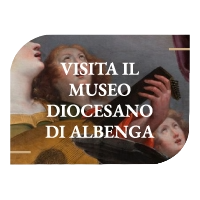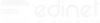La chiesa di San Giorgio a Campochiesa è nota per il famoso Giudizio Universale, che occupa l’abside centrale e nel quale è raffigurato l’episodio della Divina Commedia, in cui Dante e Virgilio incontrano il Conte Ugolino che divora il capo dell’arcivescovo Ruggeri[1]. Se, però, si rivolge l’attenzione alle numerose testimonianze pittoriche di epoche diverse che ricoprono, spesso sovrapponendosi, le pareti dell’edificio, a capo della navatella di destra si rimane incuriositi dalle scenette che animano un finto polittico ad affresco dedicato a San Biagio, databile al XIV secolo. La parte centrale della raffigurazione presenta una vasta lacuna e rivela un’ulteriore curiosità: uno strato pittorico precedente in cui, ormai solo ombre riemerse dalla memoria, compaiono, inseriti in una cornice floreale, tre Santi, fra quali l’unico ancora identificabile potrebbe essere San Paolo, che porta una spada appoggiata alla spalla (fig.1). Il lacerto è stato fatto risalire alla fine del Duecento e ha subito l’usuale picchettatura per favorire l’adesione del successivo strato pittorico[2].
Il ciclo dedicato a San Biagio, per molto tempo erroneamente identificato in San Leodegario[3], è invece ancora perfettamente leggibile e, proprio l’attento esame delle vicende raffigurate, ha permesso di svelarne la vera identità. Biagio visse tra III e IV secolo e fu vescovo di Sebaste in Armenia nei difficili momenti della prima diffusione del Cristianesimo; si pensa sia stato martirizzato sotto l’Imperatore Licinio. Di lui l’agiografia racconta la fuga dalle persecuzioni in una caverna, dove risana gli animali con il segno della croce; poi incarcerato Biagio continua a compiere miracoli e guarigioni[4].
Nelle vite dei Santi Vescovi dei primi secoli si ripete il motivo del soccorso, dell’aiuto, anche nelle piccole vicende del quotidiano, a riparare malattie, carestie, povertà o ingiustizie. E’ evidente eco del ruolo storico dei presuli, focale per la vita delle comunità, sia nel periodo della clandestinità, sia successivamente alla liberalizzazione del culto: spesso, infatti, essi si presentavano come intermediari tra la popolazione ed il potere civile del quale, soprattutto con la crisi dell’Impero, finivano per assumere anche alcune funzioni. Il porsi quale punto di riferimento, la capacità di prendersi cura, di proteggere sia il proprio gregge sia il popolo nella sua totalità sono tratti che si riflettono, quindi, nelle loro agiografie, traducendosi in miracoli per i quali vengono poi venerati quali santi ausiliatori
Il Vescovo Biagio è appunto fra essi, infatti, come si è come si è visto, è ricordato, ad esempio, mentre risana gli animali, fondamentali per la vita quotidiana, di conseguenza viene considerato protettore degli animali, oppure, proprio perché, sempre secondo l’agiografia, avrebbe salvato un bambino dal soffocamento estraendogli una lisca di pesce dalla gola, viene invocato per le affezioni della gola. E’ particolarmente interessante che, nella Leggenda aurea, la sua vicenda si concluda con il Santo che, prima di affrontare il martirio, prega Dio di concedere la salute a chiunque lo avesse invocato per una malattia della gola e per ogni altra infermità. Jacopo da Varagine raccoglie così la diffusa e fortissima fede in tale particolare virtù taumaturgica di Biagio e la fa scaturire da una sua personale richiesta[5].
In San Giorgio di Campochiesa le Storie di san Biagio, nelle quali si ricordano le sue vicende e i suoi miracoli, sono raffigurate tutt’intorno alla figura centrale del Vescovo, ritratto ieraticamente in posizione frontale, ed emergono per la loro vena narrativa, fresca, ai nostri occhi anche involontariamente ironica[6].
Il racconto inizia a sinistra e le scene sono separate dalle consuete cornici lineari, che rendono gli scomparti simili ai nostri fumetti, dei quali anticipano la narrazione per momenti fondamentali e la facilità di lettura. In alto Biagio è ritratto mentre benedice gli animali. Probabilmente il noto miracolo della lisca era raffigurato nello scomparto accanto, andato, però, quasi totalmente perduto. Sotto si notano, invece, due episodi che si susseguono con un preciso nesso. Nel primo si vede una donna prostrata ai piedi del Santo in una posa disperata e supplice, Biagio nello stesso tempo alza la mano rivolta verso un lupo che sta fuggendo sulle pendici della montagna con un piccolo suino fra le fauci. La donna è povera e implora il vescovo di aiutarla a recuperare il proprio unico maiale, cosa che, infatti, prontamente avviene, come dimostra il fatto che il lupo sta già volgendo la testa verso San Biagio, per liberare il povero animale. Seguendo fedelmente la narrazione della Leggenda Aurea, nello scomparto successivo vengono raffigurati Biagio, incarcerato subito dopo il miracolo, e di fronte al lui la donna, che sapendo del suo arresto, per sfamarlo ha per lui sacrificato il solo suo avere, il maialino (fig. 2). Secondo quanto narrato da Jacopo da Varagine, vengono portate la testa e le zampe, insieme ad un pane e una candela; negli affreschi di Campochiesa, invece, la donna porge al prigioniero il piatto su cui fa bella mostra di sé solo la testa del piccolo suino che l’ignoto autore ritrae appoggiata come un trofeo, raffigurandola con grafica precisione, quindi perfettamente riconoscibile in un mondo in cui il maiale spesso rappresentava realmente l’unica risorsa familiare (fig. 3).
L’episodio della donna e di Biagio trova nella Leggenda aurea un’interessante conclusione: il vescovo la ringrazia del dono e le dice di accendere per lui ogni anno una candela in una chiesa a lui dedicata. La donna segue la preghiera di Biagio e da quel momento inizia a vivere agiatamente. Le parole dell’agiografia ci ricordano un altro elemento iconografico che accompagna sovente il Santo: le candele. Esse sono solitamente raffigurate incrociate a ricordare la lisca di pesce del miracolo del bimbo salvato dal soffocamento, ma sono anche legate alla Candelora che si celebra il 2 di febbraio, mentre la ricorrenza di San Biagio cade il 3, e in questa occasione è tradizione che si utilizzino le candele benedette il giorno prima.
Altro oggetto molto famoso legato a San Biagio è il pettine da cardatore, che ricorda lo strumento del suo martirio; ciò ci conduce agli scomparti di destra del finto polittico, dove si vede il momento in cui il Santo viene dilaniato con uncini di ferro. Essi furono poi assimilati agli strumenti dei cardatori e dei tessitori, per tale ragione Biagio è anche loro protettore.
Nella scena accanto si assiste alla letterale trasposizione di un altro prodigio: Biagio, rifiutandosi di sacrificare agli dei, è condannato ad essere annegato in uno stagno, ma l’acqua si solidifica e diviene “come un mucchio di terra secca” tanto che il Santo non affonda né affoga, come invece purtroppo accade agli uomini mandati nello specchio d’acqua dal governatore.
Al di sotto viene raffigurata la decapitazione di Biagio, sulla cui testa, però, resta ben salda la mitria vescovile, che fa tutt’uno con il capo reciso. La raffigurazione appare ingenua, a noi strappa un sorriso, ma non si deve dimenticare che, in realtà, oltre a rendere sempre assolutamente identificabile il protagonista, tale particolare allude all’impossibilità di scindere con la morte il legame del Santo con la fede. Nell’ultimo scomparto Biagio viene deposto nel sepolcro, mentre la sua anima viene portata in gloria nei cieli, sempre con la mitria immancabilmente solidamente in capo (fig. 4).
Il ciclo, come è evidente, punta alla totale leggibilità delle vicende, all’interpretazione dei fatti priva di qualsiasi dubbio; in un mondo in cui la comunicazione passa, per la quasi totalità delle persone, solo attraverso la parola e le immagini, la certezza della comprensione del messaggio, la garanzia di un’interpretazione non eretica delle scritture viene assicurata proprio dalla chiarezza assoluta delle raffigurazioni. Per comprendere appieno questo legame, dobbiamo ricordare che le prediche, le letture rivolte ai fedeli erano accompagnate, quasi come avveniva per i cantastorie, dalla contemplazione delle chiare, semplici figure che sottolineavano l’ascolto e ne facilitavano la memorizzazione. Una volta che i fatti si erano impressi nella memora dell’ascoltatore, la semplice visione successiva delle immagini li rievocava, li rendeva insegnamento o speranza perenne.
[1] L’opera venne realizzata solo nel 1446 sopra a un ciclo pittorico preesistente (Algeri 1991, pp. 194-198), ma è tutto l’edificio a presentarsi come uno straordinario palinsesto, in cui gli interventi decorativi si sovrappongono gli uni agli altri. Le più antiche figurazioni sembrano risalire al XIII secolo.
[2] De Floriani 2011, p. 73.
[3] Per la storia della corretta identificazione, Volpera p. 177, nota 3.
[4] Sulle figura di San Biagio, la sua agiografia, la sua iconografia ed il folklore, si veda la Bibliotheca Sanctorum, terzo volume, ad vocem. Gordini, Celletti, Brandi, Vighy, coll.157-170, Roma 1963.
[5] Da Varagine , (ed. 1952, rist. 1990), pp. 174-178.
[6] Volpera 2011, pp. 165-166.
Bibliografia
- D. Gordini, M.C. Celletti, M.V. Brandi, C. Vighy, San Biagio, in Bibliotheca Sanctorum, coll. 157-170, Roma 1963.
Algeri G., Ai confini del Medioevo, I cicli pittorici del Ponente, in G. Algeri, A. De Floriani, La pittura in Liguria. Il Quattrocento, Genova 1991, pp. 194-214
- Algeri, A. De Floriani, La pittura in Liguria. Il Quattrocento, Genova 1991
- DA Varagine, Leggenda Aurea, Firenze 1990.
De Floriani A., Narrazione e decorazione a Genova e nelle Riviere, in La pittura in Liguria nel Medioevo, a cura di G. Algeri, A. De Floriani, Genova 2011, Genova 2011, pp. 65-78.
Volpera F., Dipinti murali e cicli decorativi del Ponente nella prima metà del Trecento, in, La pittura in Liguria nel Medioevo, a cura di G. Algeri, A. De Floriani, Genova 201, pp.165-178
- Algeri, A. De Floriani, La pittura in Liguria. Il Medioevo, Genova 2011