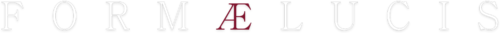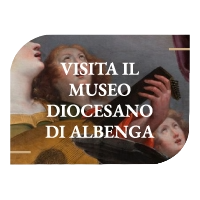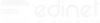È stato presentato lo scorso 12 aprile il restauro del Paliotto della cattedrale di Albenga. Un’opera di pregio, dalla storia affascinante, frutto di una manifattura veneziana e risalente al XIV secolo. Utilizzato per decorare nelle solennità l’altare maggiore della cattedrale di san Michele Arcangelo, il Paliotto giunse ad Albenga tra il 1419 e 1420.
Il restauro, interamente finanziato dalla Diocesi di Albenga-Imperia, permette oggi di ammirarlo in una nuova veste, ripulito e inserito in un nuovo contesto tra le sale del Museo Diocesano alla cui collezione appartiene. «Abbiamo voluto condividere qualcosa di particolare – sono le parole di Castore Sirimarco, direttore dell’Ufficio Beni Culturali diocesano – il Paliotto è un’opera d’arte che fa parte dell’arredo della Cattedrale e appartiene alla nostra Diocesi. È stato per lungo tempo esposto al Museo Diocesano e ora, grazie anche all’attenzione dell’Istituto di Studi Liguri, è tornato al suo splendore e sistemato in una collocazione più idonea per poterlo ammirare al meglio. È un’opera della fine del Trecento, testimonianza della storia diocesana che dobbiamo studiare e recuperare per poterla consegnare a chi verrà dopo di noi».
Lo studio di quest’opera è frutto dell’interesse di Magda Tassinari, che ha riconosciuto e indagato la preziosità del Paliotto. «Cercavo ricami del Rinascimento – spiega – grazie alla collaborazione con l’Istituto di Studi Liguri e a Josepha Costa Restagno il mio interesse si è indirizzato verso il Paliotto. Mi ha incuriosita il tipo di tecnica che insieme all’iconografia e alla committenza ha permesso poi di incrociare i dati e far emergere che si trattava di un ricamo della fine del Trecento dovuto alla committenza di Antonio da Ponte, dal 1419 al 1429 vescovo di Albenga. La ricerca non è stata lineare, è stata anzi un po’ una caccia al tesoro».
Lo studio è proseguito approfondendo tessuti simili della Dalmazia, e portando così Magda Tassinari a Silvija Banić, responsabile della collezione di tessuti europei medievali del Victoria and Albert Museum di Londra, dove è conservato il paliotto d’altare di Veglia, realizzato intorno al 1330 probabilmente su disegno di uno dei più importanti pittori dell’epoca, Paolo Veneziano, o della sua bottega. E proprio a Paolo Veneziano si rifà un corpus di opere il cui contesto figurativo si ricollega al paliotto di Albenga, così come le particolari caratteristiche tecniche e stilistiche. A sancire la peculiarità dell’opera esposta oggi in Museo, la citazione nello studio internazionale sul paliotto di Veglia, che porta il nome di Albenga nella sua ricca bibliografia.
Il Paliotto, che misura 105 cm × 278 cm, raffigura otto santi disposti ai lati della Madonna in trono, ciascuno con il nome ricamato a lato del capo, e con i propri attributi iconografici: San Cristoforo, Sant’Andrea, San Giovanni Battista, San Felice, San Fortunato, San Marco Evangelista, San Giacomo Maggiore, San Nicola di Myra. Di origine veneta, rappresenta un’occasione di studio singolare per la Liguria: pochi sono i confronti possibili, e altrettanto rare le analisi sui tessuti. A occuparsi della diagnostica è stato Paolo Bensi, chimico e storico dell’arte, già docente all’Università di Genova, che ha coordinato le analisi: «abbiamo esaminato due campioni, uno dal fondo sotto sotto il ricamo e l’altro dal filato metallico stesso – spiega -Il primo è risultato essere tinto con un colorante vegetale molto usato nel Medioevo, la robbia, in genere impiegato per la lana e non per la seta. Non sappiamo perché sia stata fatta questa scelta. Il filato, invece, è una lamina d’argento molto sottile placcata in oro, in larga parte caduto. Si vede soprattutto l’argento, spesso ossidato, quindi grigio».
Quella del Paliotto è anche una storia di restauri: l’opera odierna è il risultato di un rifacimento risalente a centoventi anni fa nell’ambito del quale è stato sostituito il tessuto di fondo originale, su cui sono stati riportati i ricami superstiti e integrate alcune lacune. Intervento drastico, quello sui volti della Vergine e del Bambino, ritagliati per l’inserimento di oleografie anacronistiche, che discordano rispetto alle altre figure. Il tessuto originale, sostituito, resta visibile nelle piccole porzioni di fondo in cui i fili di seta del ricamo sono lisi o andati perduti. La parte più preziosa è certo quella dei ricami, fragili e delicati. «Sono intervenuta sui danni agli angoli e sullo strato di polvere che, essendo stato esposto per tanti anni all’aperto senza protezione, caratterizzava in uno strato uniforme la superficie – spiega Claudia Santamaria, restauratrice specializzata in opere tessili – oltre alla pulizia l’altro aspetto critico era il ri-alloggiamento sul telaio, vuoto sul retro, non protetto dalla polvere o da azioni meccaniche: era pieno di chiodi». Il delicato restauro è durato cinque mesi: «È sempre un’emozione – racconta ancora – con grande rispetto e responsabilità ho cercato di fare un lavoro il più delicato possibile, anche in virtù della fragilità dell’opera». Un lavoro che ha ulteriormente svelato, attraverso il tipo di ricamo – l’Opus Venetum – la rarità del Paliotto.
Il restauro e il nuovo allestimento dedicato al Paliotto si inseriscono nell’anno Giubilare, contribuendo a riportare al centro dell’attenzione la cattedrale di San Michele, protagonista della storia affascinante di quest’opera.